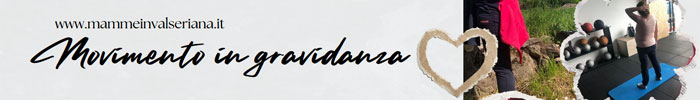C’è un terreno che da incolto è diventato un’aula a cielo aperto, un gruppo di studenti che da spettatore è diventato protagonista e un’intera comunità che ora guarda a uno spazio verde come a un nuovo bene comune. È il cuore di Radici di Comunità – Educare insieme ad Auser, il progetto promosso da Auser territoriale Valcamonica Sebino APS- ETS, realizzato con Auser Ambiente Pisogne e coordinato da Auser Lombardia con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sviluppato nell’anno scolastico 2024/2025, il progetto ha coinvolto gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Gratacasolo in un percorso che ha portato alla realizzazione di un parco agroforestale, un sistema agricolo che integra alberi, arbusti e coltivazioni dell’orto e che ha insegnato loro a produrre cibo rispettando i cicli naturali.
Oltre l’orto, un’esperienza educativa e sociale
Radici di Comunità – Educare insieme ad Auser è stato un vero e proprio laboratorio agricolo, ma soprattutto un’esperienza sociale ed educativa. L’orto e il frutteto sono diventati strumenti per insegnare ai ragazzi il valore della biodiversità, il rispetto dei tempi della natura e l’importanza di un rapporto diretto con la terra.
La dimensione didattica si è intrecciata con quella sociale e ha visto i volontari più anziani affiancare gli studenti, creando un dialogo intergenerazionale in cui competenze, storie e saperi sono passati di mano in mano. Questa trasmissione di conoscenze ha avuto un impatto concreto anche sul modo in cui i ragazzi hanno vissuto l’esperienza, e chi magari in aula faticava a emergere ha trovato nel lavoro manuale una nuova forma di espressione e riconoscimento, ribaltando le gerarchie consuete della classe.
«Chi era in difficoltà ha trovato il proprio spazio e ha mostrato capacità inattese – ha commentato Giulio Berlinghieri, coordinatore di Auser Ambiente Pisogne – Questo progetto ha insegnato il rispetto dei tempi della natura, così diversi da quelli frenetici a cui i nostri giovani sono abituati. Riportarli a una cognizione del tempo naturale, alla pazienza, all’attesa e alla cura, è forse uno dei risultati più preziosi che potevamo raggiungere». E ancora: «Non è tanto l’orto in sé l’aspetto principale, quanto la dimensione sociale e di crescita che offre. I ragazzi hanno scoperto i cicli della natura, ma soprattutto hanno sperimentato il valore della collaborazione e del dialogo tra generazioni».
Curare la terra per imparare a vivere
Il progetto, che si è sviluppato tra lezioni in classe e sul campo, letteralmente, ha introdotto gli studenti ai principi dell’agroforestazione osservando, progettando, realizzando nel concreto e soprattutto prendendosi cura di un progetto comune. Non si è trattato solo di “lavorare la terra”, ma di comprenderla come un organismo vivo.
La pratica della pacciamatura, la scoperta degli innesti, la semina e il trapianto di ortaggi hanno ad esempio insegnato che ciò che spesso consideriamo scarto – compost, foglie, residui organici – è in realtà ricchezza che nutre la vita del suolo. Accanto a questo, i ragazzi hanno sperimentato anche l’aridocoltura, la tecnica che rinuncia a irrigazioni e concimi per affidarsi ai cicli naturali, imparando che esistono alternative sostenibili all’agricoltura intensiva.
Questo approccio ha avuto una forte valenza sensoriale: toccare la terra, sentirne l’odore, assaggiare il cibo coltivato con le proprie mani. Per molti studenti è stata la prima volta che un ortaggio smetteva di essere un prodotto del supermercato e diventava il risultato di un percorso, di una cura, di un tempo condiviso.
«Coltivare significa prendersi cura di qualcosa che è vivo, che cambia, che ha bisogno di attenzione – ha sottolineato Davide Belleri, il tecnico che ha seguito gli studenti sul campo – Ho cercato di far capire ai ragazzi che la terra non è sporca, ma fertile, e che ciò che consideriamo scarto può diventare la sua ricchezza. All’inizio erano impacciati, non avevano mai preso in mano un attrezzo e sembravano lontani anni luce dal mondo agricolo. Poi, poco alla volta, hanno scoperto che potevano fare, che erano capaci. Quelli che pensavi non si sarebbero mai sporcati le mani, eleganti e attenti all’apparenza, sono stati i primi a buttarsi nella terra senza preoccuparsi di niente. È stata una trasformazione sorprendente, bastava dare loro il giusto input e si lanciavano con entusiasmo. Non sono persi, come a volte si dice: hanno solo bisogno di occasioni concrete per ritrovare un contatto con la natura e con sé stessi».
Una scuola senza voti, un’esperienza di comunità
L’impatto più forte si è avuto sul piano educativo e relazionale. In un contesto scolastico spesso percepito dai ragazzi solo come luogo di voti e prestazioni, il parco agroforestale ha offerto un’esperienza diversa, dove non si vince e non si perde, ma si cresce insieme.
Come registrato anche dagli insegnanti che hanno affiancato il progetto, le trasformazioni degli studenti sono state evidenti. Inizialmente spaesati e quasi inadeguati di fronte a un’attività lontana dai soliti schemi scolastici, e soprattutto dalla corsa alla performance e all’obiettivo di un buon voto, i ragazzi hanno progressivamente trovato il loro posto, scoprendo di poter collaborare e imparare senza la pressione della competizione. Questo percorso li ha aiutati a riconoscere il valore dell’esperienza condivisa, a rafforzare il senso di gruppo e a sentirsi parte di un progetto più grande, capace di restituire significato concreto alle nozioni apprese in classe.
«All’inizio erano spaesati – ha spiegato Antonella Taverna, insegnante di Lettere dell’Istituto Comprensivo Tenente Corna Pellegrini – poi, poco alla volta, hanno imparato a usare attrezzi mai visti prima, a riconoscere piante e ortaggi, a lavorare insieme. È stata un’esperienza che ha rafforzato la loro autostima e il senso di responsabilità».
Il progetto ha così mostrato come la scuola possa aprirsi al territorio e come attività pratiche e condivise possano trasformare concetti astratti – la sostenibilità, l’ambiente, la comunità – in esperienze vissute.
Verso un patrimonio comune
Il parco agroforestale ora guarda al futuro. Dopo la prima fase, dedicata alla messa a dimora del parco insieme agli studenti, la seconda prevede l’apertura alla cittadinanza. L’obiettivo è che diventi uno spazio vivo, frequentato e curato da tutti: bambini, genitori, nonni, volontari.
«Il prossimo passo – continua Giulio Berlinghieri – è trasformare questa esperienza in un vero parco agroforestale aperto a tutti. Vogliamo che diventi un patrimonio della comunità, un luogo dove i nonni e i genitori portino i bambini a scoprire la natura e a trasmettere loro un sapere che oggi rischiamo di perdere. Deve diventare un patrimonio della cittadinanza».
«Oggi – conclude Vincenzo Raco, Presidente di Auser volontariato di Pisogne – giunge a compimento un progetto voluto dall’Auser fin da 2020. Esso si aggiunge alle tante attività sociali svolte dai nostri volontari attivi, con l’intento di contribuire a fare crescere una comunità solidale e inclusiva, fare “Rete” con altre associazioni di volontariato e sviluppare collaborazioni con i Comuni e le Scuole del territorio. Grazie a Giulio Berlighieri e ad Auser Ambiente, ai volontari e a tutti i collaboratori che hanno permesso la realizzazione di questo importante progetto».
📲 Ricevi gratis le notizie di Montagne & Paesi sul tuo telefonino!
Iscriviti al nostro canale WhatsApp ufficiale per restare sempre aggiornato su notizie e curiosità dalle valli.
📢 Seguici anche su Telegram!
Unisciti al canale Telegram di Montagne & Paesi per ricevere tutte le news in tempo reale.